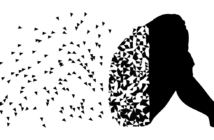Desidero affrontare l’argomento del setting gruppale come setting ottimale per la patologia borderline, chiarendo subito che non mi riferisco all’inserimento del paziente in un gruppo omogeneo a tempo determinato. Nel mio intervento odierno mi riferirò al gruppo non omogeneo, analiticamente orientato e all’interno del quale scelgo di inserire il paziente borderline.
Borderline….termine che definisce una categoria diagnostica meno unitaria e sistematizzata di quanto si possa pensare come abbiamo visto dalla presentazione fatta dal collega. Sono infatti differenti tra loro gli approcci teorici che descrivono di questa patologia, che vanno dalla centralità assunta dal danno subito dal soggetto in ambienti traumatici e traumatogeni, al versante dell’instabilità e della superficialità relazionale, a quello della strumentalità e della aggressività distruttiva, a quello dei meccanismi difensivi primitivi. I punti di concordanza riguardano la natura sfuggente e difficilmente inquadrabile della sindrome, che ne rende sfumati i confini diagnostici e non favorisce la messa a fuoco di un principio organizzatore di spiegazione esaustivo. Vi sono comunque dei punti di concordanza che si coagulano intorno alla grave carenza delle forme affettive nelle relazioni famigliari, deficit che hanno contribuito a determinare sentimenti di profonda solitudine per l’assenza di introietti positivi e che determinano una estrema fragilità nelle relazioni interpersonali, esplosioni rabbiose e una instabilità affettiva.
In altre parole il soggetto borderline è un soggetto ipersensibile nelle relazioni interpersonali, poco capace di modulare in maniera adattiva il distanziamento altrui e, massimamente il rifiuto altrui per gli atteggiamenti e le modalità aggressive del suo stesso comportamento prevalentemente proiettivo. Il rifiuto altrui o una risposta non sintonica, generano nel soggetto borderline sentimenti di rabbia e solitudine, che si sovrappongono ad un sentimento di vuoto radicale interno e di inconsistenza di sé, tutti inneschi di stati d’animo quali l’angoscia abbandonica e la depressione abbandonica. A questi stati d’animo il borderline risponde difensivamente, passando all’atto nel tentativo di sottrarsi alla percezione di affetti estremamente penosi. In questo senso e ad esempio, il tentativo di suicidio, il gesto auto-lesivo, i comportamenti auto-mutilanti, la tossicodipendenza compulsiva sono modalità atte ad eliminare un sentimento di depersonalizzazione che comporta vissuti di svuotamento e annichilimento del Sé, agiti funzionali alla gestione del dolore come strategia estrema per alleviare la tensione interna e sollecitare il sostegno esterno (Linhean, 1993; Zanarini, 1993). Ai fattori patogeni menzionati, vanno aggiunte le situazioni in cui, invece e per contrasto, può essere l’iperprotettività dell’oggetto primario, intesa come “controllo senza partecipazione affettiva”, ad incidere negativamente sullo sviluppo del Sé. Infine patogenetiche sono le situazioni in cui l’abuso fisico o quello sessuale sono stati perpetrati. Ognuna delle situazioni costituiscono fattori traumatici, conclamati o cumulativi, che contribuiscono a sviluppare stati dissociativi, pur se di diversa entità rispetto alla loro profondità ed estensione, non consentendo alcuna rielaborazione degli affetti e generando una situazione di malessere soggettivo molto pervasivo.
Se la parte della psiche dissociata tende, per un qualsiasi evento, a rientrare nel campo di coscienza, i ricordi vengono agiti e non ricordati, perché gli affetti ad essi collegati si manifestano in maniera altamente angosciosa e insopportabile. La dissociazione non annulla la sofferenza, la isola: il soggetto avverte se stesso come emozionalmente morto, inerte, affettivamente slegato sia dal suo mondo interno che dal mondo delle relazioni interpersonali. Questi patterns psicologici e comportamentali mostrano il loro potere patogeno perché non conducono ad alcuna esperienza di simbolizzazione e di comunicazione interpersonale ma pongono l’individuo, reiteratamente, nello stallo traumatico originario, rendendo a questo punto il soggetto stesso incarnazione della vittima e dell’aggressore. Una follia che non è del pensiero, ma delle emozioni, ragione per cui coglierne il senso in una condivisione diventa perno del lavoro terapeutico. Quando dunque Alessandro, il paziente borderline di cui avrò modo di parlare, nel corso di una seduta intervenne affermando: “Ehi, ci sono io dentro me stesso!”, il gruppo e la sottoscritta reagirono a questa affermazione con partecipazione emotiva profonda e con autentica sorpresa. Stava avvenendo una comprensione esperienziale degli stati emotivi, l’inizio di una capacità di mentalizzare le emozioni e i sentimenti attraverso la sperimentazione diretta di quel sentimento di essere dentro se stesso, di determinare una rappresentazione dello stato mentale esperito.
L’attenzione rivolta alla comprensione dei processi relazionali che hanno delineato lo sviluppo del soggetto nel corso della sua vita e quelli che caratterizzano le sue relazioni attuali, è ovviamente con ogni paziente il focus del processo terapeutico, ma ancor più la significazione esperienziale delle emozioni è fattore dirimente con pazienti così gravemente compromessi. Le riflessioni sul processo maturativo della mente e dell’apparato affettivo, aprono interrogativi su come diventiamo ciò che siamo, obbligandoci ad estendere le nostre considerazioni sulle forme di interazione che intercorrono tra l’ambiente e il bambino. Un ambiente famigliare e sociale fondamentale e fondativo, poiché è quell’ambiente che “ci dona a noi stessi “, attraverso le infinite modalità di trasmettere, prima di tutto all’infante, la sua individualità essenziale e la percezione di chi esso sia (Winnicott, 1997; De Monticelli, 2003).
Fu quindi con autentica sorpresa anche per se stesso che Alessandro, che a lungo aveva sostenuto di non riuscire a ricordare o a pensare alcunché di significativo che lo riguardasse, affermò nel corso di una successiva seduta particolarmente drammatica per i ricordi che stavano emergendo e che coinvolgevano tutto il gruppo emotivamente, che stava capendo che “la sua rabbia era dovuta al fatto che aveva sempre pensato al mondo come luogo odioso, indegno da vivere”. Tecla, una paziente del gruppo, gli chiese a quale mondo si riferisse ed Alessandro precisò che intendeva riferirsi al “suo” mondo: un mondo che non era stato “degno di accoglierlo”. Questa affermazione di Alessandro mi fece pensare alla carenza di “aiuto vitale”, al deficit di nutrimento affettivo, ad un mondo/ambiente inaffidabile su cui nessuna forma di controllo può essere esercitata dal bambino che vive se stesso in uno stato di impotenza, incertezza e pericolo che producono un grave vissuto depressivo. In queste situazioni si verifica una rottura del “sistema vivente”, quel sistema cioè che riguarda la modalità dell’esistenza e la sua complessità, finalizzate entrambe a predisporre il soggetto verso la familiarità delle emozioni che vengono a perdere il loro significato specifico di esperienza e di scambio (Sander 1991, Winnicott). Le valenze affettive si coagulano in una forma satura di rabbia e di umiliazione senza una misura contenitiva, la cui assenza genera conflitti emotivi intollerabili che inibiscono ogni forma di rappresentazione mentale di sé in relazione all’esperienza. L’emozione che dovrebbe essere aiuto realistico ad apprendere dall’esperienza, diviene invece un nemico da tenere a distanza, distorcendo il modo stesso di avere presa su di esso. Non sussistono le condizioni per costruire un’alternativa a quel mondo in cui si deve vivere, per lungo tempo infatti non può essercene un altro possibile. La rabbia, la paura, la frustrazione e l’umiliazione rimangono esperienze emotive prive di nome e di possibile trasformazione perché manca un codice espressivo condiviso tra la madre e il bambino. Ogni forma di abuso successivo si innesta su questa prima condizione depauperante che genera difensivamente i primi processi di scissione, accentuandone l’intensità.
E’ sulla base di queste considerazioni che penso al gruppo non omogeneo e analiticamente orientato come setting elettivo di questa tipologia di pazienti ipersensibili alla vicinanza emotiva. All’interno del gruppo prende vita una dialettica modulativa che lo rende naturalmente uno schermo protettivo consono a filtrare i passaggi emozionali tra i vissuti soggettivi e quelli interattivi. Tra il dentro e il fuori.
Questi passaggi qualora troppo intensi non sarebbero infatti tollerabili dal paziente borderline che è prigioniero di una dis-regolazione emotiva che produce un senso di incoerenza di sé e di inadeguatezza relazionale che solleciterebbe troppo modalità oppositive e di attacco e fuga dalla relazione. L’organizzazione di una funzione di filtro, generata dagli scambi interattivi tra i membri, lavora per una continua regolazione del rapporto con la realtà attraverso il riconoscimento delle diversità che richiede una contrattazione continua e una delimitazione della volontà di travalicare e manipolare. Nell’interazione tra loro i membri del gruppo “vedono” ed esperiscono sé in relazione con l’alterità. La rabbia espressa può disorientare alcuni, ma essere compresa da altri. Il legame può incrinarsi senza distruggere, per poi tornare a ricomporsi in modo pieno. Il gruppo infatti agisce su un livello doppio perché da una parte è “oggetto-sé” che modula la relazione, in un ideale e ricercato continuum di risonanza empatica per il recupero di un rispecchiamento ottimale. Dall’altra si esprime in tutta la sua realtà alteregoica che rende, psicologicamente ed emotivamente riconoscibile al soggetto stesso, il suo modo di vivere sé nella relazione con gli altri pazienti, cioè con il gruppo nella sua totalità e con il terapeuta (Paparo e Nebbiosi, 2000).
E’ un passaggio di grande importanza euristica, perché il paziente apprende progressivamente ad uscire dalla logica della reiterazione di sé come vittima dell’affetto traumatico, e può constatare in quale misura egli abbia identificamente introiettato le interazioni danneggianti e come esse agiscono nelle relazioni della sua vita. Si costella nel paziente, e in tutto il gruppo come conseguenza, un’esperienza che a tutti gli effetti è un vero e proprio momento organizzatore della psiche (Ibid.). Ma sussiste anche un altro vantaggio riguardo al progetto terapeutico in gruppo, perché questo tipo di setting assolve, insieme, una finalità psicologica e pedagogica. Finalità quest’ultima essenziale per avviare i processi di alfabetizzazione affettiva con questi pazienti (Zucca Alessandrelli, 2009, Fina 2015). I due aspetti, psicologico e pedagocio, entrano in risonanza l’un l’altro, in un profondo nesso dinamico che li unisce e che contribuisce a determinare nuovi percorsi emotivi ed affettivi. Anche per questo motivo il gruppo concorre a modificare i vissuti che sono relativi non solo ad un prima – l’infanzia – e ad un dopo – l’adesso, agendo un cambiamento per tutto ciò che attiene, appunto, al rapporto inerente il “dentro” e il “fuori”.
Nel gruppo, questa dinamica lascia emergere più rapidamente e con maggiore forza il significato interpersonale e intersoggettivo delle configurazioni intrapsichiche che sono parte costitutiva del Sé, in quanto il gruppo e i suoi componenti sono incarnazione, nel qui ed ora, delle relazioni e degli affetti, sono disponibili a identificazioni che ribadiscono la necessità della dimensione relazione con l’altro in quanto simile e non in quanto identico, contenendo l’area della delusione e del vissuto di perdita che questa differenza evoca. Il gruppo ha una intima funzione convalidante dei bisogni rimasti inascoltati da un ambiente inadeguato, ma l’altro – gli altri- sono come me e a un tempo diversi perché separati-da-me.
Nel setting gruppale infine il paziente non viene identificato tout court con la sintomatologia psichica di cui è portatore, cosa che tenderebbe alla reificazione del soggetto, ma genera curiosità come persona e interesse per la sua sofferenza psichica. Senza essere collocata all’interno di categorie diagnostiche, la storia di ciascuno restituisce ai soggetti il senso esperienziale di Sé. (Zanardi, 1999).
Non ho ancora presentato Alessandro – lo faccio ora.
Alessandro è un uomo di cinquant’anni, sposato da 18 e con due figlie. La primogenita ha compiuto da pochissimo 18 anni, la secondogenita ha 14 anni. Alla sua nascita il padre abbandonò la famiglia trasferendosi in un’altra città. La madre entrò in una profonda crisi depressiva, allevò il figlio da sola scegliendo di non risposarsi, probabilmente mantenendo viva dentro di lei la speranza di una ricongiunzione con il marito, che in realtà scomparve dalla loro vita. Il paziente ha il ricordo di una madre emotivamente fredda, i cui occhi “erano persi nel nulla”, molto operativa nel suo accudimento che era sbrigativo, nervoso. “Ho sempre pensato che mia madre vedesse in me il marito, che fossi il testimone vivente del loro fallimento”.
Alessandro ha iniziato la terapia con me circa cinque anni fa. I primi due anni in un setting duale, a cui è poi succeduto l’inserimento in gruppo. Fui contattata dal paziente dopo molte resistenze, mi disse. La moglie, in terapia da un collega, aveva posto un aut-aut: o l’analisi o la separazione. La signora a quel tempo non era a conoscenza dell’abuso di cocaina, o meglio, non voleva sapere di sapere della tossicodipendenza del marito, che data dai suoi quindici anni di età, con un passaggio da cannabinoidi alla cocaina intorno ai venticinque. Il paziente ha dunque attraversato la sua adolescenza, giovinezza e inizio della maturità senza mai essere stato astinente. La moglie era stata una sua compagna di ginnasio, per qualche anno dipendente da eroina è totalmente astinente da oltre diciotto anni, cioè dalla sua prima gravidanza. Entrambi laureati e professionisti, provengono da un ambiente sociale più che benestante. La motivazione per cui Emma, la moglie del paziente, fu insistente sull’inizio di una terapia analitica del marito era dovuta all’insofferenza ormai definitiva verso il suo comportamento: repentini passaggi d’umore che dall’abulia passavano a stati euforici incontrollabili per poi tornare ad accasciarsi in uno stato di disperazione totale. Emma era ormai intollerante agli scatti irosi del marito, alle violenza verbali incontrollate contro le bambine, alle scenate continue. Era insofferente alla inaffidabilità del coniuge che “dimenticava” le figlie, lasciandole fuori dalla scuola a volte per ore; era rabbiosa per le continue dimenticanze di Alessandro che saltava gli appuntamenti con i clienti e che disertava le udienze in tribunale. Un quadro famigliare ed esistenziale disastroso, tenuto insieme da una parvenza di adattamento garantito prevalentemente dal benessere economico di cui entrambi beneficiano.
Alessandro si sentiva da parte sua colpevole e del tutto inadeguato a gestire la famiglia e ad essere genitore. La sera, prima di rincasare si stordiva con la cocaina, di cui aveva già abusato nel corso della giornata. Aveva ripetuti incidenti in auto che avevano comportato il ritiro della patente. Rimaneva sveglio fino a notte tardi per poi non riuscire ad alzarsi al mattino. Spesso arrivava, alle poche udienze che ormai riusciva a presenziare, in condizioni di alterazione da sostanza e con l’angoscia di essere scoperto. Per i primi due anni di terapia ho seguito il paziente in un setting individuale con due sedute settimanali. Ho così conosciuto un uomo disperatamente solo, diffidente verso di me e verso il progetto terapeutico.
Schiacciato dalla costante angoscia delle conseguenze, sul piano professionale e personale, delle sue intemperanze comportamentali che lo rendevano del tutto inaffidabile e che avevano determinato una involuzione lavorativa che sembrava essere irreversibile. Pensava di smettere con la cocaina in modo onnipotente, ripetendo “ da domani basta, così tutto andrà bene”. Come se l’astinenza fosse a portata di mano, come a portata di mano era la cocaina: lì, pronta ad “essere assunta”. Non riuscendo in questo intento tornava a farsi per non sentirsi annichilito dall’impotenza. Rifiutava categoricamente un sostegno farmacologico come progetto terapeutico da affiancare alla terapia. Non voleva, a suo dire, diventare dipendente dai farmaci. Il lavoro in quei due anni fu mirato prevalentemente a costruire una fiducia di base, per fondare una relazione con me che lui potesse sperimentare come affidabile. Durante le sedute, svolte vis a vis, Alessandro mi scrutava. All’inizio con una modalità di sfida, alzava il tono della voce, rigettava qualsiasi osservazione. Ogni mio commento era da lui vissuto come critica distanziante oppure come troppo sollecitante l’area emotiva. Decisi allora che non avrei più commentato il suo modo di scrutarmi, lasciando invece che Alessandro lo utilizzasse in funzione di ciò di cui aveva bisogno, vale a dire vedere il suo stato emotivo riflesso nel mio volto. “Forse oggi sono più depresso che incazzato ….” “….forse è la paura che mi fa paura”…. e si fermava, in attesa di una conferma da parte mia. Era un’area di “gioco condiviso”, uno scambio relazionale non verbale ma denso di significati, che riusciva ad attenuare i vissuti paranoidei e l’angoscia generata dall’inadeguatezza e dalla vergogna. L’inizio di una lavoro comune che, al di fuori della consapevolezza, contribuiva a caratterizzare la relazione stessa come mutativa. Una “corrispondenza percettiva” mirata a costruire una “categoria affettiva” che modificava il registro percettivo-sensoriale del paziente. Fu questa comprensione a farmi capire che il passaggio in gruppo sarebbe stato un passaggio strategico per l’evoluzione della terapia. Alessandro accettava ormai quel gioco a due, ma incalzava a un tempo per la conclusione del lavoro con me. Provava benessere perché si sentiva compreso, ma era troppo forte l’emozione per la risonanza emotiva che quel gioco sollecitava. Era molto faticoso per Alessandro stare a contatto con quella risonanza, si sentiva fragile e timoroso perché percepiva il legame tra noi come una nuova forma di dipendenza, altrettanto pericolosa della cocaina, e per questo costrittiva e assoggettante.
La proposta del passaggio in gruppo fu oggetto di valutazione attenta a cui fu dedicato molto lavoro. Mi interessava esplorare con lui le sue fantasie e le sue aspettative sul gruppo. Le sue paure e le sue difese, che erano molte e catalizzate prevalentemente intorno al sentimento della vergogna. Ma la sua accettazione fu un atto di fiducia, che ebbe un enorme significato per lui e contribuì a delineare la costruzione di un ponte tra esperienza intima e capacità di comunicazione condivisa, grazie alla funzione contenitiva del gruppo che lo rende un dispositivo di cura capace di attivare le trasformazioni dei vissuti percettivi in forme di dolore condivisi e pensati, facilitatore di livelli funzionali necessari al raggiungimento di una regolazione affettiva adeguata al procedere stesso della terapia analitica.
Vi presento ora il gruppo in cui Alessandro viene inserito, precisando che i due passaggi che riporterò riguardano sostanzialmente eventi accaduti nel primo biennio di inserimento del paziente, il periodo più difficile. Alessandro viene inserito nel mio gruppo più anziano, il mio primo gruppo che ha ormai più di vent’anni di vita. Ha una storia stratificata che contribuisce a renderlo particolarmente “maturo e sostenitivo”. Al suo interno sono passati molti pazienti difficili. E’ un gruppo composto da nove persone, tre uomini e quattro donne, la terapeuta e l’osservatrice partecipante. All’inserimento di Alessandro, Maria è in analisi da poco meno di cinque anni. Giulia, da tre anni mentre Marisa, la più “anziana” del gruppo, è in analisi da 8 anni e prossima alla conclusione. Tecla, ha alle spalle poco meno di due anni di lavoro e Gabriele invece sei.
Come lavora il gruppo e come io lavoro nel gruppo
Premetto subito che ritengo sempre attive nel gruppo due dimensioni transferali: verso l’oggetto-sé e verso il transfert ripetitivo. L’analista deve essere in grado di gestire entrambe le dimensioni del transfert che possono “pescare” a livelli differenti nel mondo affettivo e psicologico del paziente. Affermerei anche che il transfert di oggetto-sé si sviluppa prevalentemente nei confronti di un membro del gruppo, mentre il transfert ripetitivo trova la sua formula espressiva nei confronti di tutto il gruppo. Un membro del gruppo può sperimentare, ovviamente, un transfert ripetitivo con l’analista e contemporaneamente un transfert d’oggetto-sé verso il gruppo-come-un-tutto o semplicemente verso un membro del gruppo. L’analista deve poter gestire tutte queste dimensioni transferali ed esplicitarle sia al paziente che al gruppo.
Prima vignetta (a otto mesi dall’inizio della terapia)
All’inizio di una seduta successiva all’interruzione estiva Alberto, un membro del gruppo, chiede di parlare per primo e racconta, riferendosi ad un’episodio di cui era stato testimone un particolare giorno sulla spiaggia, un ricordo che lo aveva turbato e che riguardava la sua dolorosa esperienza di bambino. Durante il racconto Alberto si blocca perché, dice, gli sembra di cogliere una disattenzione del gruppo per la sofferenza da lui espressa e si commuove. Tecla cerca un fazzolettino nella sua borsa e glielo porge. Questo gesto, denso di significato affettivo, modifica lo stato d’animo del paziente, che riprende il suo racconto ricordando come, nelle situazioni di tensione con la madre, il padre si assentasse, ritirandosi nel suo studio, privandolo così di un sostegno emotivo. Alessandro interviene in modo dispregiativo e svalutativo verso la reazione di Alberto, parla del padre che lo aveva abbandonato poco dopo la sua nascita. Man mano che il racconto procede, il tono emotivo diventa sempre più violento e rabbioso. Suo padre, scomparso per oltre quarant’anni, è ricomparso recentemente ormai anziano, dopo la morte della seconda moglie, con la pretesa di rientrare nella vita di Alessandro per conoscere le nipoti. Le parole vengono vomitate e via via che il racconto continua, i nessi logici e i significati cognitivi si perdono, diventano confusi. Maria interviene: “Ale, questa rabbia ce la stai buttando addosso! Non riusciamo ad ascoltarti”. Marisa a sua volta afferma: “qui non si fa a chi soffre di più….Non funziona così… Siamo tutti sulla stessa barca di dolore”. Il gruppo intero rivolge lo sguardo alla terapeuta, Alessandro si accomoda sulla sedia, allunga le gambe e incrocia le braccia.
Il mio intervento riprende la reazione di Alberto, il cui ricordo genera dolore per l’assenza di un tempo e ora rivissuta nel silenzio del gruppo, mentre Alessandro reagisce con rabbia perché quello stesso silenzio è anche per lui il penoso silenzio paterno. C’è bisogno di ricevere cura ed attenzione ma c’è anche la paura di entrambi che il gruppo e la terapeuta siano come genitori insensibili, incapaci di capire i bisogni e di riconoscere le richieste che vengono loro rivolte. Maria afferma che la sofferenza non è esclusiva prerogativa di qualcuno contro qualcun altro. Gabriele, il più riflessivo e ironico del gruppo afferma: “mi sa che siamo tutti messi alla prova, lei per prima dottoressa”. Già, ma di quale prova sta parlando Gabriele? Secondo Tecla, Alessandro attacca il gruppo perché ha la coda di paglia, è stato assente per due sedute di fila dopo che tutti gli hanno dedicato l’intero tempo di una seduta per capire come doveva cavarsela con la figlia scoperta a fumare erba. “Non ti abbiamo più visto perché era l’ultima seduta prima dell’estate. Tu fa sempre così. Ci coinvolgi e poi sparisci. Non ti rende conto che anche noi abbiamo bisogno di te perché con te siamo noi ad essere coinvolti”. Tecla ribadisce che anche lei tante volte ha pensato di non ripresentarsi in seduta, di abbandonare la terapia, perché è faticoso gestire le relazioni che coinvolgono. “Ha ragione Marisa, siamo tutti sulla stessa barca, può non piacerci ma ci siamo. La fuga serve solo dimenticare che siamo fragili e che siamo stati impotenti”. “Fuggire è come illudersi che ogni sentimento negativo svanisca o che rimanga isolato e quindi innocuo”, affermo io. Esiste una grande variabilità di risposte emotive individuali, continuo, tra le quali per esempio l’idealizzazione di una condizione nella quale una persona pensa di riuscire ad attraversare situazioni difficile e drammatiche senza dolore, ritenendo che questo sia un segno distintivo per acquisire forza e non sentirsi soccombere.
Cosa è successo in questa seduta?
- L’esperienza del qui ed ora è il ponte tra il passato e il presente. Immediatamente a disposizione dei pazienti i cui vissuti focalizzati sullo scambio interattivo, evocano le rotture traumatiche già esperite nei legami originari, riproducendoli nei vissuti attuali che questa volta possono essere compresi e non subiti.
- L’interazione e lo scambio intersoggettivo permangono, e grazie alla presenza attiva del terapeuta, i pazienti esperiscono in modo pieno e significativo nuove configurazione di sé in relazione con l’alterità.
- Il gesto di Tecla che porge il fazzoletto ad Alberto genera una comprensione della fragilità emotiva che viene condivisa e convalidata.
- Così come è accaduto per la reazione di Alessandro, nonostante sia proiettata nel gruppo, in modo espulsivo, un’angoscia per lui intollerabile.
- Si è verificata una elaborazione emotiva avvenuta inizialmente al di fuori della consapevolezza cosciente, ma grazie al codice espressivo del gruppo vengono condivisi sentimenti come l’ansia, il dolore, la paura, la frustrazione che non rimangono più esperienze emotive non finalizzate e quindi prive di senso. Nello spazio gruppale anzi gli sguardi, i gesti, i silenzi, le parole diventano tutte esperienze altamente evocative di quei gesti, di quegli sguardi, di quei silenzi, già vissuti un tempo, e rimasti disconosciuti e incompresi. Si attivano micro-processi e modelli di interazione che costituiranno nel tempo il cambiamento psicoanalitico, quei “momenti ora” che organizzano le prime rappresentazioni mentali delle emozioni e dei sentimenti.
- Il gruppo acquisisce doti di holding e di attesa, di capacità di non interpretare subito ma di cercare piuttosto il significato nascosto nelle espressioni più arcaiche e nelle eccitazioni emotive come quelle espresse da Alessandro, cercando di riflettendo sul modo in cui esprime i suoi bisogni e le sue urgenze nascosti nelle esplosioni rabbiose.
Valorizzare con osservazioni e interpretazioni mirate ogni passaggio comunicativo ed espressivo, contribuisce a ricostruire un tessuto affettivo ed emotivo vitale per la psiche, passaggio che diviene un ponte tra il verbale e l’affetto non verbalizzato ma agito, verso la direzione di un sapere di sé e su di sé finalmente pensato insieme. In tal modo si possono raggiungere le parti più arcaiche del paziente, senza correre il rischio di indugiare troppo in vissuti regressivi. “Ale questa rabbia ce la stai buttando addosso!”, l’affermazione con cui Marisa si rivolge ad Alessandro, è un altro modo di porgere il fazzoletto. Due modalità comunicative che, entrambe, diventano espressioni di réverie vitale nello scambio pre-verbale.
Seconda vignetta ( a 18 mesi dall’inserimento di Alessandro in gruppo).
Il gruppo sta affrontando da qualche seduta una complicata situazione perché Alessandro è ricaduto in un abuso compulsivo della cocaina dopo sei mesi di astinenza. Qualche mese prima il paziente aveva deciso di comunicare con una lettera alla moglie le ragioni del suo comportamento inaffidabile e violento. Prima di consegnare la lettera a Emma, Alessandro l’aveva letta al gruppo: era molto commovente, calda. Sostanzialmente si scusava di averle mentito occultando una condizione di tossicodipendenza così grave. Ne spiegava le ragioni e chiedeva il suo aiuto affettivo, confortato dal fatto che la terapia analitica sarebbe stato l’altro perno su cui poter fare affidamento. Soprattutto, le chiedeva di aiutarlo nel rapporto con le bambine. La reazione di Emma, da parte sua, era stata affettuosa. Sembrava avere capito bene le difficoltà del marito e aveva dichiarato che lei stessa in qualche modo si sentiva responsabile di non averlo capito, di non averlo potuto aiutare, di non avere voluto vedere. Poche sedute dopo, Alessandro irrompe nel gruppo furioso e comunica l’intenzione di Emma di comunicare alla figlia più grande quale sia la situazione paterna. Afferma anche che i segreti di famiglia determinano un non detto che lavora negativamente nei vissuti dei figli e lo invita a considerare una separazione fino al raggiungimento della sua astinenza totale. Alessandro si sente umiliato e angosciato, molto preoccupato della reazione che potrebbe avere sua figlia, ha paura di perderla.
Il gruppo si coalizza contro Emma che viene stigmatizzata per il suo comportamento. La terapeuta viene attaccata: perché non pensa di bloccare Emma, di contattare il suo terapeuta per indurlo a farla ragionare? Perché non sa calmare le angosce di Alessandro? Perché non sa capire cosa sta succedendo? Che senso ha continuare la terapia se non si prevede una protezione dei pazienti e del gruppo in casi simili?
Circola un’angoscia di disgregazione determinata da un evento inaspettato, che irrompe nel gruppo e che genera emozioni così forti da rendere impossibile, in quel momento, l’individuazione di un senso plausibile dei fatti. Il sentimento di condivisione regredisce su un versante che confonde la partecipazione e il sostegno empatico con l’identificazione massiccia. La necessità di ricevere protezione da parte della terapeuta è molto forte, del tutto simile a quella desiderata da una madre che deve poter estirpare il dolore in modo magico e onnipotente. A queste considerazioni aggiungo che non ho il potere di trovare soluzioni che siano magiche ed immediate. Che ho bisogno di pensare, che abbiamo bisogno di pensare per capire.
Il gruppo si placa e Maria racconta il suo sogno della notte prima, nel quale la paziente si trova alla guida della sua auto. Si sta rimirando nello specchietto retrovisore e perde così di vista l’auto davanti alla sua, che frena d’improvviso, rendendo l’urto inevitabile. Con inquietudine, la paziente a quel punto si sdoppia e assiste alla scena osservandola da fuori. E’ colpita dal fatto che il suo corpo viene penetrato dall’auto davanti, e in successione da tutte le altre automobili in fila per il tamponamento. Maria riferisce con estrema chiarezza descrittiva che ogni auto le passa attraverso, come se il suo corpo avesse perduto la consistenza di cui è fatto, così come avviene per i fantasmi che attraversano le pareti. Si sveglia profondamente turbata.
Il gruppo è colpito dalle immagini oniriche per la pregnanza che esse hanno. Tecla coglie un’analogia tra l’impatto subito da Maria nel sogno e l’impatto subito dal gruppo per il racconto fatto da Alessandro. Maria riprende il suo racconto, associando al sogno la realtà dei suoi numerosi interventi di chirurgia estetica dovuti al suo “bisogno vitale” di modificare i suoi tratti somatici. Alberto interviene sottolineando a sua volta che il tamponamento multiplo di cui Maria è vittima, è una espressione del vissuto che sta circolando nel gruppo rispetto a quello che Alessandro ha raccontato. Giulia pensa che Alberto forse ha colto un aspetto importante, ma a lei viene in mente che il sogno racconta come Maria si pone nella relazione con tutti loro. Secondo Giulia, Maria è sempre protesa a mantenere un’idea di sé eterea, per un desiderio/paura di essere vista solo per la sua bellezza. Gabriele racconta a sua volta il sogno che ha fatto la notte prima, in cui è alla angosciosa ricerca di un cadavere che anni prima aveva nascosto. Marisa pensa che tra i due sogni c’è un nesso, perché entrambi hanno a che fare con un corpo. Gabriele parla della madre, della sua continua ansia e ipocondria sempre proiettata su di lui. Ricorda anche che una paura materna era quella che il figlio potesse ”cadergli dalle braccia” e che per questo motivo veniva collocato nel box di gioco fino all’arrivo del padre, la sera. Alessandro chiede aiuto al gruppo. “Cosa posso fare? Anzi no, cosa devo fare?”. Maria, che ha ascoltato con un’attenzione viva e dolorosa, racconta che quando era bambina sua madre la portava a comperare gli “abitini”. La madre le proponeva queste uscite come un gioco, come un loro “piccolo segreto” da custodire. Per la paziente quei momenti sin erano trasformati, via via nel tempo, in momenti di grande paura. Una paura terribile e angosciosa, provata per sé e per la mamma. Era prassi della madre fare indossare alla bambina, nel camerino di prova, diversi strati di “abitini” e di occultarli sotto il suo vestitino. Maria diventava così il manichino dei furti materni. La bambina non riusciva a ribellarsi, né a parlare con il padre di questo, perché si vergognava. Nel tempo questa “cosa segreta” era diventata “cosa normale”, e infatti la paziente la narra in gruppo con una certa meraviglia, affermando che è strano come le siano potuti tornare in mente simili ricordi. Era qualcosa a cui non aveva più pensato. Alessandro è emozionato dal racconto di Maria, “è importante questo ricordo, lo hai nascosto a te stessa, come fai ora con la chirurgia plastica. Anche per me forse c’è stata l’esperienza di essere un “corpo manichino, non mi sentivo umano. In realtà, non mi sono mai posto il problema in questo senso, posso solo dire che il racconto di Maria mi coinvolge in modo particolare, mi commuove ma mi fa anche arrabbiare”.
Molte considerazioni sono possibili sulle dinamiche interne al gruppo che sono intercorse in questa seduta. Mi soffermerò su quelle che ritengo particolarmente pertinenti al tema di oggi, sintetizzandole per punti.
- Sul versante negativo. La decisione della moglie di Alessandro circa il coinvolgimento della figlia. E’ un fatto che contribuisce a disorganizzare il pensiero e l’affettività del marito. Il racconto di Alessandro irrompe nel gruppo, attivando una forma di contagio psichico che genera forme di difesa primitive, di tipo borderline, che rendono difficile al gruppo poter distinguere il vissuto percepito dalla realtà, stabilendo piuttosto uno stato di equivalenza psichica.
- L’inibizione difensiva della capacità di pensare i propri stati interni rende tutti i pazienti particolarmente vulnerabili a fronteggiare l’intensità delle reazioni e impedisce l’accesso ad una modalità di funzionamento mentale.
- Questi fattori comportano l’insorgenza e la polarizzazione di emozioni negative che invadono i contesti intersoggettivi rimanendo non codificabili.
- Sul versante positivo. Nel setting gruppale il gradiente di intensità dei vissuti negativi inizialmente scissi e proiettati (in questo caso su Emma come soggetto del danno), possono avvicinarsi tra loro emotivamente grazie al valore simbolico delle immagini oniriche e delle associazioni che connettono il “là ed allora” al “qui ed ora”, trasformandosi in rappresentazioni dense di significato. Sul piano transferale, la molteplicità delle rappresentazioni nel contesto gruppale genera una similarità emotiva che permette l’individuazione di nuovi significati circa il modo di essere e di comprendere gli altri. In tal modo il legame può esprimersi secondo una logica al contempo di similarità e di differenza.
- Nel primo caso, quello della similarità, si determina una situazione del tutto simile a ciò che accade quando il bambino scopre se stesso come parte integrante dell’ambiente che lo circonda. Il senso emergente di appartenenza, alla base dei suoi processi di rappresentazione simbolica, dipende dalla qualità dell’affetto che accompagna questo complesso processo e rappresenta per la psiche l’essenza stessa della raffigurabilità delle percezioni sensoriali e corporee che diventano emozioni pensabili (Paparo ed al. 1990 ).
- Nell’emergere delle differenze, invece, si apprende il valore della tolleranza e della ricchezza insita “nell’altro diverso da me”, aprendo il soggetto all’esperienza di comprensione e rispetto. Nel gruppo analitico eterogeneo la costruzione di legami simbolici è, infatti, promossa dalle differenze che lo compongono e che sono anzi esse stesse espressione, nell’ hic et nunc, di possibilità nuove e più mature. Il valore del legame è dovuto sostanzialmente alle differenti empatie e alle differenti esperienze di vita dei componenti del gruppo e l’esperienza alteregoica diviene esperienza soggettiva che promuove la crescita. (Corbella, 2015).
E’ in tal senso che il gruppo offre sempre molte opportunità di esplorazione intersoggettiva, rompe le barriere e precostituisce nuove forme di attaccamento. Le forme di interazione che nascono all’interno del gruppo sono espressione “degli stati affettivi ed emotivi che trovano una loro forma espressiva e organizzativa nuova e alternativa, permettendo ai membri del gruppo di accedere ad uno dei fattori terapeutici più potenti che la terapia di gruppo possa fornire” (Paparo e Nebbiosi, pag.113).